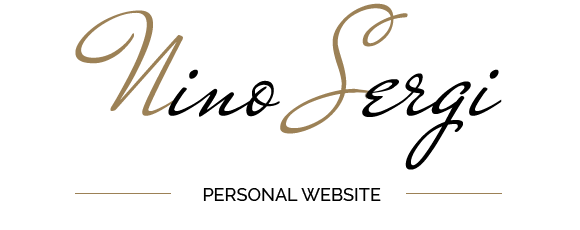La dimensione strategica delle ONG: il ruolo delle Ong nei conflitti. Tesi di laurea – Anno Accademico 2018/19
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE – Corso di laurea in Relazioni Internazionali –
Laureando: Giacomo Toni – Relatore: Prof. Paolo Quercia
MIE RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL LAUREANDO GIACOMO TONI
PRIMA PARTE
- L’autrice Fiona Terry parla di paradosso umanitario in merito agli scenari in cui gli aiuti umanitari contribuiscono a prolungare il conflitto piuttosto che alleviare le sofferenze. Ad esempio, fornendo protezione ai cosiddetti refugee-warriors, sostenendo l’economia di guerra, dando legittimità ad una parte del conflitto e facilitando il controllo della popolazione (Condemned to Repeat? The Paradox of Humanitarian Action, Cornell University Press, 2002). Cosa ne pensa al riguardo? Si è mai trovato in una situazione da paradosso umanitario?
- La giornalista Linda Polman espone nei suoi testi il dilemma umanitario (in particolare: L’industria della solidarietà. Aiuti umanitari nelle zone di guerra, Bruno Mondadori 2009). Una ONG che si rende conto di non poter operare in condizioni di imparzialità, indipendenza ed universalità, come dovrebbe agire? Il dilemma era già cominciato nel XIX secolo con Henri Dunant e Florence Nightingale. Il primo credeva fosse giusto aiutare tutti in ogni caso, mentre la seconda riteneva corretto scegliere di non aiutare se questo significava prolungare le sofferenze. Un esempio è la scelta del ritiro della sezione francese di MSF nel 1994 dai campi profughi in Zaire durante la guerra civile in Ruanda. Lei concorda con la scelta del ritiro o ritiene sia meglio restare in ogni caso?
- Lo storico Luttwak ritiene che le ONG prolunghino le sofferenze ed i conflitti bloccando l’evoluzione naturale della guerra. Infatti, secondo lo studioso, una guerra non si potrà mai risolvere se si interviene a sostegno di una delle parti. Quanto concorda con questa idea? Cosa ne pensa?
- Si verifica che nei campi profughi vi siano due categorie di rifugiati. I cosiddetti genuine-refugees, i quali sono civili che necessitano cure ed assistenza e poi ci sono i refugee-warriors: combattenti che, mischiati tra i civili, godono della stessa assistenza e possono quindi recuperare le forze per poter tornare a combattere. Come poter evitare la militarizzazione dei campi? Vanno assistiti solamente i genuine–refugees?
- I conflitti ormai vengono definiti crisi umanitarie. In questo modo gli Stati scaricano la responsabilità sulle ONG/organizzazioni umanitarie? Cosa ne pensa?
“” Le domande seguono uno stesso filo conduttore. Più che brevi risposte separate, preferisco un’unica articolata e complessiva risposta che comprenda e leghi insieme tutti i punti.
Occorre evidenziare, come prima cosa, che nessuno dei citati, né Fiona Terry, né Linda Polman, né Edward Luttwak, sostiene che l’aiuto umanitario non serva. Sarebbe come affermare che non serva salvare vite umane, alleviare sofferenze, proteggere persone in fuga o che non servano l’impegno a garantire cibo, istruzione, salute, la lotta a povertà, fame, mancanza di acqua potabile.
Nonostante le inevitabili limitatezze, gli interventi umanitari rimangono un imperativo, un obbligo, a meno di voler rinunciare ad ogni valore umano nelle nostre società. Proprio perché si tratta di un imperativo, ogni intervento deve rispondere nel miglior modo possibile agli specifici bisogni delle differenti situazioni, nella consapevolezza che ogni persona va salvata, aiutata, protetta, accompagnata. Per chi opera in organizzazioni umanitarie hanno peso emozioni, passioni, coinvolgimento personale, relazioni umane intense. Ma queste non bastano: sono richieste anche specifica idoneità, professionalità, capacità di leggere i contesti in cui si opera, specie se si tratta di situazioni di conflitto. Non sono permesse improvvisazioni, anche se spinte dalla generosità. Chi si dedica agli interventi umanitari deve acquisire conoscenze e competenze, accettando con molta umiltà un cammino di apprendimento e di crescita: e ciò vale sia per le persone sia per le organizzazioni.
Le critiche e gli interrogativi sull’operato delle organizzazioni umanitarie sono molti e non dobbiamo temere che siano evidenziati. Ci aiutano a riflettere, ad analizzare meglio, a migliorare le nostre strutture e la nostra azione, a prendere decisioni più attente. Ciò che non piace è la superficialità e stupidità delle critiche, il sensazionalismo, la strumentalizzazione politica, la ricerca forzata e falsata dello scoop denigratorio. Gli aspetti critici che sono evidenziati nelle domande toccano la dimensione politica e i principi umanitari.
Le emergenze umanitarie, in particolare quelle che si prolungano nel tempo, sono per lo più causate da conflitti, con le distruzioni, le morti, gli odi, le violenze, le persecuzioni, le diverse pulizie a carattere etnico, politico o religioso, gli sfollamenti che producono. In quei contesti la dimensione politica è dominante, influisce su tutto ma è a sua volta sensibile a fattori esterni. Anche l’azione umanitaria può diventare uno dei fattori che possono influire sui conflitti. Dopo i primi doverosi interventi per proteggere e accogliere persone in fuga e alla ricerca di protezione, ogni organizzazione deve decidere le successive programmazioni basandosi su un’attenta conoscenza e analisi del contesto e degli attori in gioco, valutando i possibili effetti positivi e negativi della propria azione. Lo stesso imperativo umanitario, cioè l’assoluto dovere di soccorrere le popolazioni in pericolo, deve essere vissuto con questa attenzione.
Gli aiuti possono perfino diventare una componente della guerra, aiutando i combattenti e contribuendo al prolungamento degli scontri. Si tratta di effetti involontari, certo, ma non per questo da sottovalutare. Ciò può succedere in particolare quando le organizzazioni umanitarie, per portare i soccorsi, accettano imposizioni dell’uno o dell’altro dei contendenti senza soppesarne attentamente le conseguenze. Si tratta di imposizioni quali il pagamento di tasse di transito, la cessione di percentuali di cibo o di altri beni di prima necessità in cambio dell’autorizzazione a operare, limitazione delle aree da soccorrere, indirizzando così gli aiuti in alcune zone e vietandoli in quelle che si intende ripulire e spopolare. Può inoltre succedere quando nei campi di rifugiati capita di soccorrere, tra le innumerevoli persone in cerca di aiuto, quelle che approfittano della protezione umanitaria per riorganizzarsi, riarmarsi e tornare a combattere. L’imparzialità dell’aiuto, in casi come questi, può trasformarsi in vera parzialità, perché favorisce e rafforza la parte che intende continuare lo sterminio o comunque le ostilità. Ogni organizzazione è tenuta a valutare attentamente queste situazioni, finanche a decidere la modifica o la cessazione dell’intervento. Non farlo sarebbe segno di impreparazione e superficialità.
Ogni organizzazione umanitaria si trova spesso di fronte a scelte difficili. Il confronto con le altre organizzazioni nazionali e internazionali operanti nell’area è normalmente utile per meglio valutare quelle da adottare al fine di garantire comunque soccorso umanitario. Anche il confronto con le istituzioni del proprio paese è talvolta utile, pur mantenendo la propria autonomia e indipendenza. Ma, alla fine, è la singola organizzazione umanitaria che dovrà decidere. E lo fa normalmente con grande senso di responsabilità. Per questo, ogni scelta che cerchi di rimanere coerente con i principi umanitari prestando attenzione alle conseguenze delle proprie azioni merita rispetto. Ed è dovere di tutti, in particolare nel nostro paese, cercare di capirne il senso e le motivazioni e di guardare al mondo umanitario senza pregiudizi politici e senza insensate divisioni per logiche di appartenenza.
Lo ‘spazio umanitario’, giustamente preteso dalle organizzazioni umanitarie che necessitano di libertà di azione, autonomia e indipendenza rispetto a poteri e istituzioni che hanno altre finalità, non è mai concesso incondizionatamente, anche quando affermato da accordi internazionali o dagli stessi contendenti. Lo si conquista eliminando ogni possibile stortura o ambiguità nell’azione umanitaria, adottando decisioni e comportamenti chiari e comprensibili a tutti, ai belligeranti e alle popolazioni, per farla riconoscere e percepire immediatamente per quello che è, umanitaria, senza possibilità di confusioni. Anche in questi casi, se la percezione esterna rimane ambigua, dubbia, come nelle situazioni dove c’è confusione dei ruoli tra noi umanitari e i militari, la valutazione potrà portarci – come è successo – alla sospensione dell’aiuto in tali aree, quando diventa l’unica via percorribile per essere identificati come umanitari e unicamente come tali. Si tratta infatti di un problema molto serio che, se non affrontato adeguatamente, rischia di modificare e forse annullare lo ‘spazio umanitario’ costruito e codificato universalmente in ben 150 anni di impegno della Croce Rossa Internazionale e successivamente delle Ong, delle Agenzie umanitarie dell’ONU, degli Stati che hanno ratificato convenzioni e adottato solenni impegni in merito, compresa l’Unione Europea con il ‘Consensus sull’aiuto umanitario’.
La stessa neutralità dell’operatore umanitario, che non significa non essere consapevoli dei torti e delle ragioni dei contendenti e dei crimini commessi, va pienamente vissuta, ma fino al limite di non favorire col silenzio o una neutralità che potrebbe rasentare l’indifferenza, una parte, quella più prepotente e criminale, rispetto all’altra. Uno stretto rapporto con le organizzazioni dei diritti umani può essere, in alcuni casi, la via da seguire. Così procedendo, si riesce a denunciare gli atti criminali, senza però esporsi direttamente e quindi evitando l’espulsione dal paese, in modo da poter continuare il soccorso alle vittime dei crimini. In altri casi, invece, per aiutare queste stesse vittime, potranno essere necessarie la denuncia e la testimonianza pubblica, anche a costo di essere immediatamente espulsi dal paese.
Conoscenza e analisi dei contesti, valutazione dei rischi, autorevolezza e forza per rifiutare imposizioni inaccettabili, fino alla sospensione degli interventi quando vengono meno le condizioni per poterli realizzare nel dovuto modo: è questo il background culturale e operativo dell’Ong che ho diretto per anni, INTERSOS, e di ogni organizzazione umanitaria degna di questo nome. Il lavoro umanitario, per essere davvero tale, richiede capacità che non si improvvisano, perché deve saper fornire in tempi rapidi risposte a decine di migliaia di persone bisognose di tutto, a partire dalla protezione e dalle necessità vitali. La qualità dell’aiuto richiede necessariamente qualità in chi intende esercitarlo. Occorre riconoscere che in Italia non è sempre stato così. A nessuna Ong è infatti richiesta la capacità di conoscere e capire i motivi del conflitto, le parti che si contrappongono, la migliore tipologia degli aiuti, gli effetti dei propri interventi umanitari, le possibili manipolazioni da parte dei regimi o dei contendenti, di avere cioè gli strumenti per poter assumere le decisioni umanitarie più corrette e per saperle attuare. Un medico, un infermiere, un avvocato non possono esercitare se non ne hanno i titoli. Per l’azione umanitaria pare invece valere qualsiasi ‘buona azione’, qualsiasi ente, qualsiasi persona; la preparazione e la professionalità sono spesso viste, da chi in Italia avvalora l’ideologia della ‘più ampia partecipazione’ sempre e comunque, come elitarismo e chiusura. A ciò ha contribuito anche la nostra pubblica amministrazione e talvolta la politica, più propense ad accontentare tutti che non a esigere severi criteri di selezione. La professionalità, l’efficienza e l’efficacia sono connesse anche alla solidità strutturale dell’Ong, che non è necessariamente collegata alla grande dimensione ma all’importanza data a formazione, competenza, esperienza, insieme a spinta valoriale e dedizione del personale, adozione di un preciso modello di organizzazione, gestione, e controllo, di procedure per le attività. I comportamenti, la sicurezza, chiarezza amministrativa, trasparenza e accountability attraverso una comunicazione propensa a dare conto di tutto e a renderlo verificabile. È un cammino che molte Ong hanno decisamente intrapreso in questi ultimi decenni.
Va inoltre evidenziato un altro aspetto. Troppo spesso gli aiuti umanitari degli Stati (come gli interventi militari) sono la foglia di fico che nasconde la “nudità” della politica, le sottovalutazioni, i ritardi, l’incapacità di intervenire e di prevenire, che portano ad assumere decisioni quando ormai ogni iniziativa politica è diventata impossibile e l’intervento umanitario (o quello armato) risultano inevitabili. In alcuni casi si ha perfino la sensazione che non vi sia alcuna volontà politica di porre fine alle crisi, che si prolungano per anni e che permettono grandi profitti a chi vive sulle guerre e sull’insicurezza (dalle armi alla logistica e alle forniture, dalla vigilanza alla sicurezza, fino allo schizzare del costo generale della vita ovunque vi siano interventi internazionali). La politica, aiutata dalla diplomazia, dovrebbe contribuire a dare le risposte adeguate per prevenire i conflitti o per riuscire a contenerli con interventi puntuali, mirati ed efficaci. Ma da molto tempo sembrano non esserne più capaci.
Le Ong umanitarie non accettano di diventare strumenti della politica o, peggio ancora, essere occasione di giustificazione della guerra. Non faranno sconti a nessun governo su questo punto. Respingiamo la guerra come strumento per la soluzione dei conflitti. Oltre alle conseguenze devastanti immediate sulla popolazione civile, la guerra ha dimostrato di non riuscire a risolvere i problemi, ma soltanto di modificarli, di postarli nel tempo, quando non di peggiorarli. Essa è la chiara evidenza del fallimento dell’iniziativa politica e dell’incapacità o della mancanza di volontà di intervenire in tempo utile per prevenire i conflitti con mezzi e risorse adeguati. Pur non escludendo a priori la possibilità di presenze militari armate, in particolare per il mantenimento della pace, decise da Istituzioni legittimate e con l’accordo di tutte le parti in conflitto, rifiutiamo il concetto di “intervento militare umanitario” o peggio ancora di “guerra umanitaria”.
SECONDA PARTE
- Le ONG non sono elette da nessuno e spesso intervengono per mancanza di volontà politica da parte degli Stati. In ogni caso, le loro azioni hanno delle conseguenze. In che grado e di chi sono responsabili le ONG? Chi rappresentano?
- ONG in Italia. Come poter portare il dibattito pubblico oltre la strumentalizzazione politica? Perché ci si ferma al Mediterraneo senza allargare la visuale?
“” I soggetti non profit della cooperazione allo sviluppo sono regolati dalla legge 125/2014 e dalle disposizioni attuative. L’articolo 26 della legge elenca le tipologie di Osc, organizzazioni della società civile senza finalità di lucro che possono essere soggetti della cooperazione pubblica allo sviluppo. In particolare: a) Ong specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario (riconosciute con decreto ministeriale di idoneità ai sensi delle precedente legge 49/1987); b) Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali, statutariamente finalizzati alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale. Sono iscritti allo specifico Elenco presso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo che ne accerta i requisiti con periodiche verifiche. I responsabili di queste organizzazioni non sono eletti “dal popolo”, non presentandosi a svolgere alcun ruolo politico rappresentativo o di governo. Ma sono normalmente eletti dalla loro base sociale, trattandosi perlopiù di associazioni regolate e controllate (ora, secondo anche le disposizioni della nuova normativa sul Terzo Settore).
Le Ong e Osc che intervengono nelle realtà di crisi umanitarie agiscono anche indipendentemente dalle istituzioni italiane. Collaborano con le istituzioni locali e con istituzioni pubbliche europee, multilaterali o regionali che contribuiscono al finanziamento delle attività. Talvolta agiscono direttamente, con fondi privati. Ciò avviene normalmente per interventi che completano quelli pubblici, o nelle fasi iniziali di un’emergenza, oppure in sostituzione dello Stato o altra autorità pubblica che, per ragioni politiche o altre motivazioni, non rispondono ai propri doveri (sanciti da norme costituzionali e da una lunga serie di trattati, convenzioni e accordi internazionali che troppo spesso vengono oscurati).
Chi rappresentano? Sono espressione di quella parte di società civile responsabile che vive i principi della solidarietà, del rispetto dei diritti e della dignità di ogni essere umano, della giustizia sociale ed economica, della convivenza, della pace, e cerca di attuarli agendo con coerenza sul proprio territorio e ovunque vi siano gravi bisogni.
E’ ormai riconosciuto da tutti che molti dei problemi sociali trovano soluzione solo grazie all’impegno delle organizzazioni non profit (che sono anche motori di cambiamento capaci di guardare al futuro e che rappresentano inoltre una parte rilevante dell’economia italiana, in grado di produrre servizi e beni e di garantire occupazione). Quelle impegnate all’estero sono riuscite a creare ponti di dialogo e partenariati per lo sviluppo e ad assicurare una presenza solidaristica in situazioni di grave crisi umanitaria, spendendosi in prima persona e sentendo la responsabilità di rappresentare talvolta l’unica presenza italiana in quei contesti.
Sono responsabili delle loro azioni, certo, come tutti. E quando sbagliano sono perseguibili, come tutti. Qualsiasi realtà pubblica o privata e qualsiasi persona che contravvenga alle leggi dello Stato, truffando, ingannando, calpestando i dettami costituzionali e subordinandoli dolosamente ad interessi personali o di gruppo, deve essere condannata e all’occasione sanzionata. A maggior ragione se si tratta di enti non profit con obiettivi solidaristici. Sulle conseguenze delle loro scelte umanitarie, la riflessione esce però dai codici civili o penali. Già nella prima parte ne ho parlato: ogni organizzazione umanitaria deve saperle valutare e deve saper prendere le corrette decisioni in merito. Una particolare ‘conseguenza’ è che spesso – e forse sempre più frequentemente – le Ong mettono gli Stati di fronte alle loro responsabilità senza dare tregua. Importante sarebbe riuscire a farlo aprendo anche un dialogo serio con le istituzioni, fermo, severo ma costruttivo, che tenga nel dovuto conto le ragioni reciproche e che trovi punti di convergenza, forse non sul ‘meglio’, con alto valore ma spesso quasi solo simbolico, ma sul ‘bene’ raggiungibile e duraturo. Solo di fronte alla negazione, per basse motivazioni politiche, di diritti e doveri inalienabili, il dialogo diventa difficile o anche impossibile.
Mentre il lavoro umanitario delle Ong è diffuso in tutto il mondo, lì dove le crisi colpiscono gravemente le popolazioni, l’attenzione dei media e della politica si è concentrata sul Mediterraneo, con una intenzionale visione chiusa e strumentale (“le Ong non portano voti”, “le notizie umanitarie di paesi lontani non interessano, non si vendono”). Sulle organizzazioni che, in assenza dello Stato, si impegnano nei salvataggi in mare, serve qualche elemento di chiarezza, data la strumentale confusione e gli ingiustificati attacchi che ci sono stati. I soggetti coinvolti sono chiamati genericamente (e talvolta impropriamente) Ong. Alcune sono organizzazioni consolidate e molto conosciute sia in Italia che a livello internazionale. Altre sono state create tra il 2014 e il 2017, proprio a seguito dei numerosi naufragi. Complessivamente sono state una dozzina (ridottesi a quattro nel 2019), spinte dalla mancanza di iniziativa politica di fronte ai crimini contro l’umanità che si compiono ai nostri confini, appena al di là del Mediterraneo. Di fronte all’inerzia e il cinismo dei governi, esse hanno voluto e vogliono offrire almeno una risposta: salvare vite umane. Non hanno certo voluto, come è stato invece affermato, “imporsi sulle politiche migratorie dello Stato sovrano”, “agire n contrasto all’interesse nazionale”, né “favorire l’immigrazione irregolare”, né “mettere in pericolo la sicurezza nazionale”. Il loro intento è stato ed è solo quello di salvare la vita di esseri umani, dal mare e dal crimine. E l’hanno fatto proprio perché da un lato lo Stato, gli Stati non hanno avuto la capacità di adottare politiche condivise per governare una realtà in continua e progressiva espansione, cercando di guardare lontano nello spazio e nel tempo invece di chiudersi in difesa dei propri confini con la testa nella sabbia a mo’ di struzzo; e dall’altro lo Stato, gli Stati hanno avuto paura di assumere le proprie responsabilità, limitandosi troppo spesso a beciri e improduttive strumentalizzazioni elettoralistiche.
Le politiche governative da anni hanno bloccato gli ingressi regolari, legali, controllati, sicuri. Si è quindi lasciato libero spazio a criminali e mafie internazionali che hanno ingannevolmente propagandato la facilità dell’emigrazione illegale, incentivandola e sfruttandola a proprio vantaggio. Si è parlato di Ong pull factor, taxi del mare, e non è certo mancata nelle organizzazioni umanitarie la riflessione sull’aiuto che involontariamente può essere fornito ai trafficanti che ne approfittano organizzando l’arrivo massiccio di migranti, lucrando su viaggi insicuri e rischiosi. Di fronte però all’incapacità dei governi e della comunità internazionale, severi a parole sui crimini commessi in Libia sui migranti ma immobili e incoerenti nella realtà, è prevalso sempre l’imperativo di salvare le vite, finché possibile. Un esempio di fedeltà a principi inalienabili, coerenza e profonda umanità. Il vero fattore di attrazione è l’aver lasciato campo libero all’irregolarità e all’illegalità, senza alcuna capacità di governo dei movimenti migratori, subendo l’iniziativa dei criminali invece di contrastarla ristabilendo adeguati e ponderati criteri di immigrazione regolare, basata anche su accordi di vera cooperazione e mutuo interesse con i paesi di partenza. Proprio perché regolare, ordinata e sicura (come indica il Global Compact on Migration), essa non sarebbe affatto un’invasione e avrebbe l’effetto di togliere spazio a criminalità e mafie mettendo un freno efficace agli ingressi illegali e alle morti in mare e lungo le rotte di terra.
Un nuovo approfondito dialogo tra istituzioni e organizzazioni della società civile su questo tema sarebbe più che opportuno. Non è impossibile. Occorre disponibilità e apertura all’approfondimento da parte istituzionale innanzitutto (cosa non scontata), ma anche da parte non governativa (non sempre capace di abbinare proposte realizzabili alle giuste richieste). E’ bene anche rendersi conto che spesso alla politica e alle istituzioni mancano le conoscenze specifiche e la visione della realtà che spesso le organizzazioni umanitarie invece hanno, dato il loro impegno concreto, e che sono indispensabili insieme alla visione ed alle esigenze interne per potere assumere corrette decisioni. Non sempre prevale la strumentalizzazione politica, che rende il dialogo difficile: quando possibile, e senza nulla togliere alla chiarezza delle posizioni, il confronto aperto tra Istituzioni e Ong potrebbe portare veramente e seriamente a decisioni più coerenti, positive e lungimiranti.
TERZA PARTE
- Quanto dipendono le ONG dalla politica estera dello Stato di appartenenza?
- Quale sarà nel futuro il ruolo delle ONG nei conflitti? Acquisiranno sempre più potere o saranno gli Stati a dettare ancora le regole?
- Cosa si prospetta per il futuro del mondo delle ONG? Quali sono i cambiamenti che auspica?
“” Le Ong normalmente non dipendono dalla politica estera dello Stato ma decidono autonomamente, in modo indipendente. Vi può essere però coincidenza di visione e di approccio, specie di fronte a emergenze umanitarie gravi, ma non dipendenza. Spesso poi lo Stato non ha una precisa politica estera di fronte a situazioni e problemi complessi come quelli che le Ong si trovano ad affrontare. La domanda che poni può invece, più precisamente, riferirsi ai finanziamenti statali quando le Ong li richiedono. Da alcuni sono considerati fondi che condizionano e quindi rendono meno indipendenti le Ong. In realtà non è vero, o non è sempre vero, che il finanziamento pubblico comprometta l’indipendenza e l’autonomia delle scelte delle Ong. Per INTERSOS non è stato raro riuscire, al contrario, a orientare le scelte pubbliche, intervenendo con autorevolezza e convincenti motivazioni, riuscendo a fare sistema tra pubblico e privato, senza alcuna rinuncia all’indipendenza. Quando le Ong partecipano ai bandi di EuropeAid sull’acqua, sull’agricoltura, sull’ambiente, sull’energia o su altro, per un paese o una serie di paesi bisognosi, sono esse che valutano la scelta dei partner, dei luoghi in cui intervenire e delle comunità con cui condividere finalità e obiettivi. Sono scelte che non si differenziano da quelle fatte per progetti realizzati con fondi privati. Anche i finanziamenti europei di ECHO non minacciano l’indipendenza delle Ong umanitarie. Così quelli di OCHA, UNHCR, UNICEF, la cui unica condizione può essere la richiesta di inserirsi in un programma più ampio e coordinato di interventi, anche per evitare di fare tutti la stessa cosa fornendo la stessa tipologia di aiuto: una condizione utile e giusta. I fondi pubblici normalmente non compromettono l’indipendenza. Il problema sta nella capacità di essere indipendenti e di rimanere fedeli ai principi umanitari, nella capacità di essere propositivi, nell’autorevolezza dell’Ong, nella storia e nell’esperienza acquisita. Se l’Ong è invece impegnata nella ricerca di fondi per poter fare qualsiasi cosa, senza capacità propositiva e senza autorevolezza, allora il problema può esistere davvero.
Il ruolo umanitario delle Ong nei conflitti si sta purtroppo riducendo, essendosi ridotto il riconoscimento dello ‘spazio umanitario’ e quindi del valore dell’azione delle Ong, privilegiando spesso l’azione militare, definita anch’essa ‘umanitaria’, con attività ‘umanitarie’ finalizzate alla “conquista delle menti e dei cuori” dei civili e subordinate agli obiettivi militari. E’ necessario che venga definita una netta distinzione tra interventi umanitari e interventi militari, fossero questi anche di puro mantenimento della pace. Il linguaggio, in questi casi, è anche sostanza e deve essere assolutamente appropriato. Occorre che agli interventi armati sia data la giusta definizione, senza ambiguità e possibilità di confusione, chiamandoli con il loro vero nome: intervento di protezione, di mantenimento della pace, di separazione dei contendenti, di imposizione del cessate il fuoco ecc., evitando così ogni confusione con l’intervento umanitario che è senza armi, non subordinato ad altri interessi, basato sui soli valori e principi di umanità, sul diritto all’aiuto, sulla presenza quotidiana e solidale con le persone in pericolo. Si tratta di un punto di estrema importanza e attualità. La nuova strategia militare considera infatti che anche l’azione umanitaria, direttamente gestita dai militari, debba far parte del “proprio mestiere”, per rendersi amiche le popolazioni, contenerne il sentimento ostile, ottenere più facilmente informazioni utili. È sempre stato così, ma da ormai due decenni la dimensione assunta è spesso esageratamente ampia, esplicita, talvolta concorrenziale con le stesse organizzazioni umanitarie, creando confusione e rendendo difficile l’indispensabile riconoscibilità dell’azione umanitaria. La chiarezza della distinzione dei ruoli e delle attività è indispensabile e urgente. Sarà solo su queste basi di chiara e riconoscibile distinzione dei ruoli che potranno essere ipotizzate appropriate forme di coordinamento e anche di collaborazione tra l’umanitario e il militare nei contesti di crisi.
Non è indispensabile, per il mondo delle organizzazioni umanitarie, che la politica e le istituzioni italiane capiscano che il nostro lavoro rappresenta anche uno straordinario valore italiano nel mondo, da tenere in considerazione e di cui andare fieri. Non è questo infatti che interessa al lavoro umanitario che segue ben altre logiche e obiettivi. Rimane però difficile capire l’ostinata sottovalutazione di questo valore da parte di molti politici e di molti rappresentanti delle istituzioni del nostro paese. Peccato per loro. E per il nostro Paese.